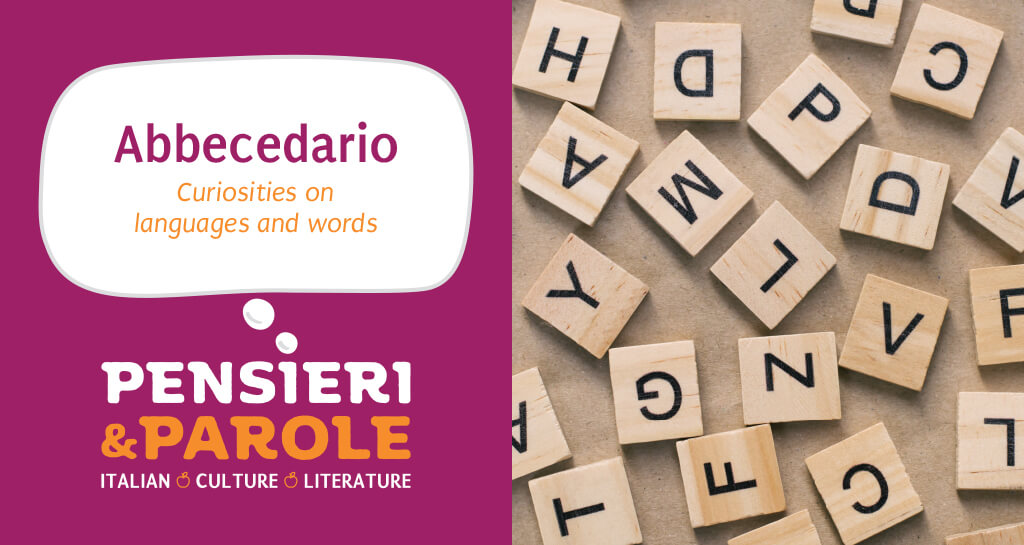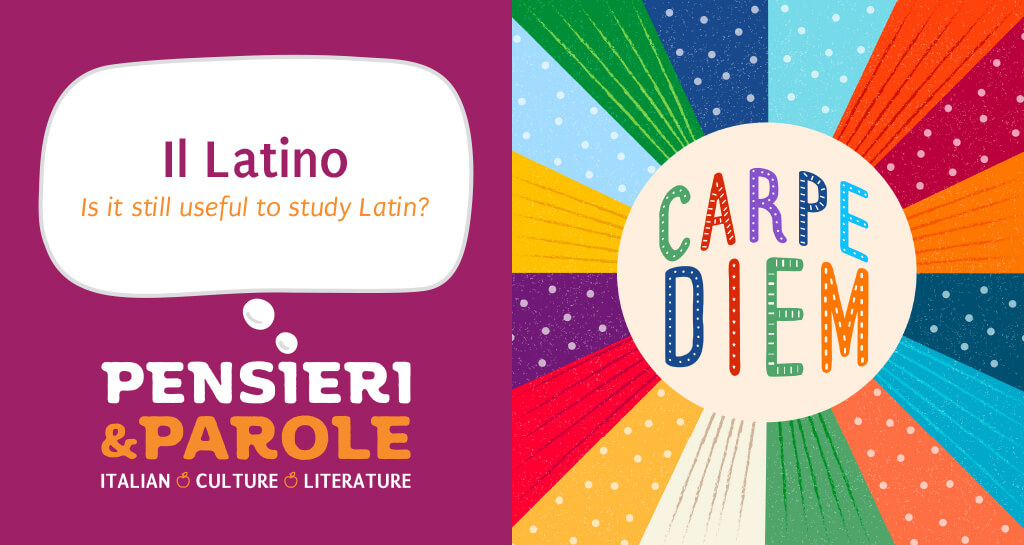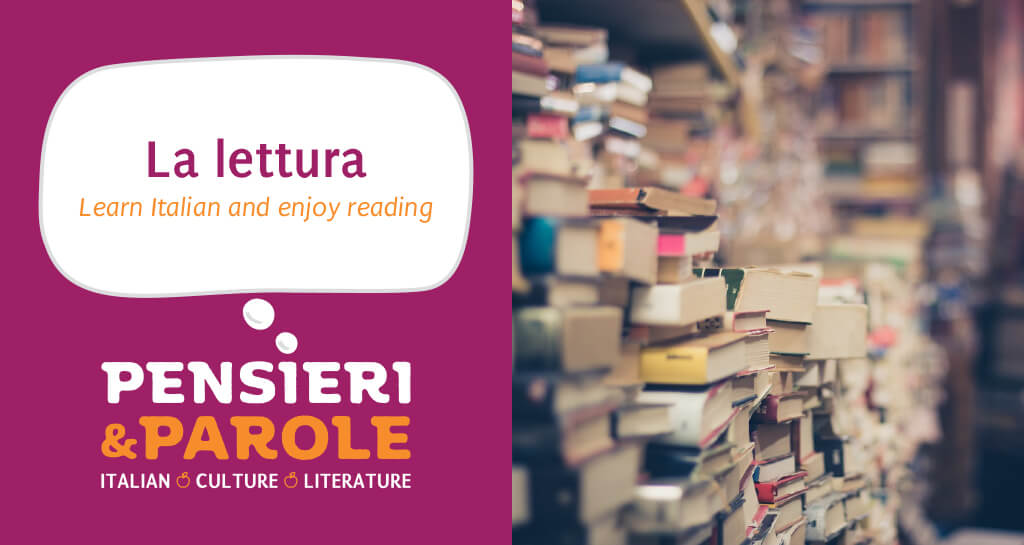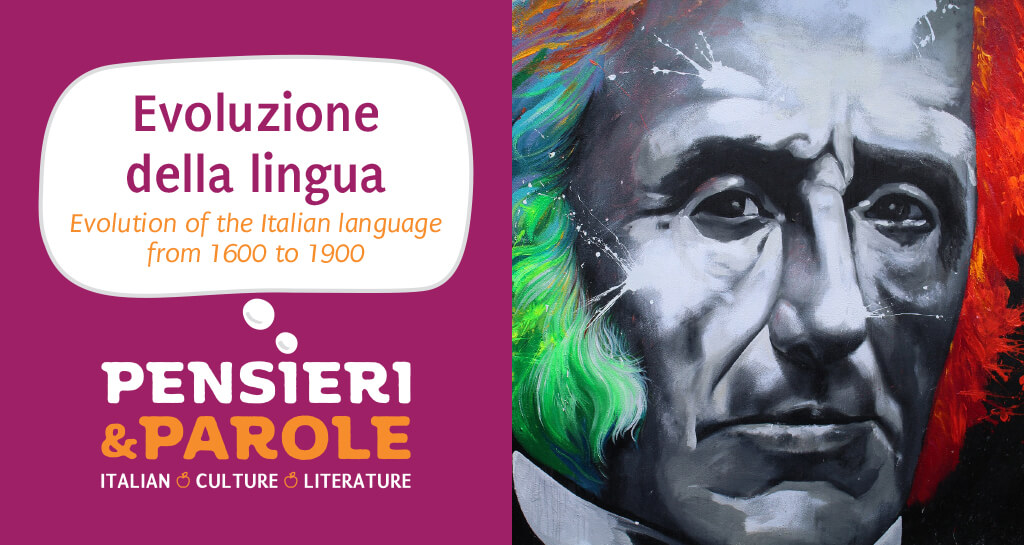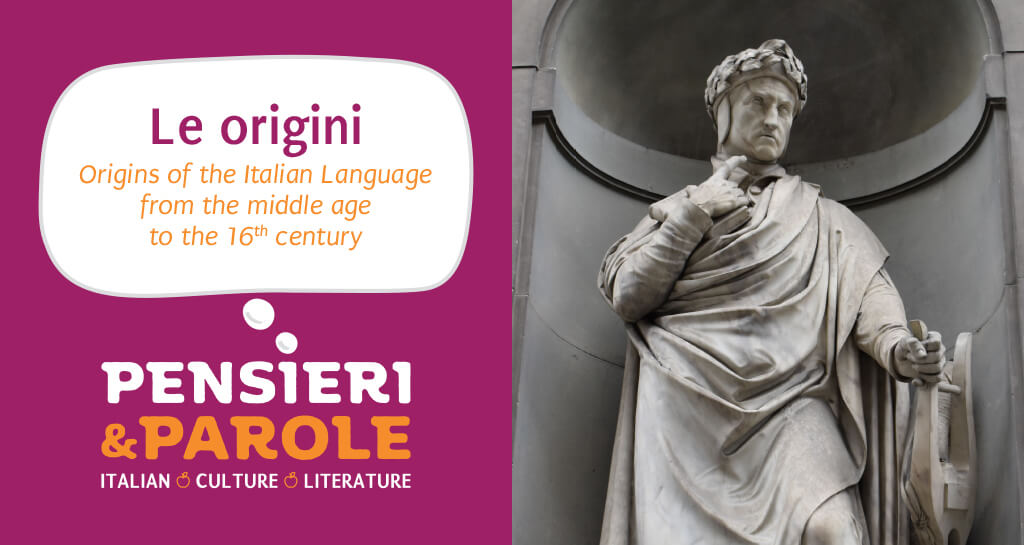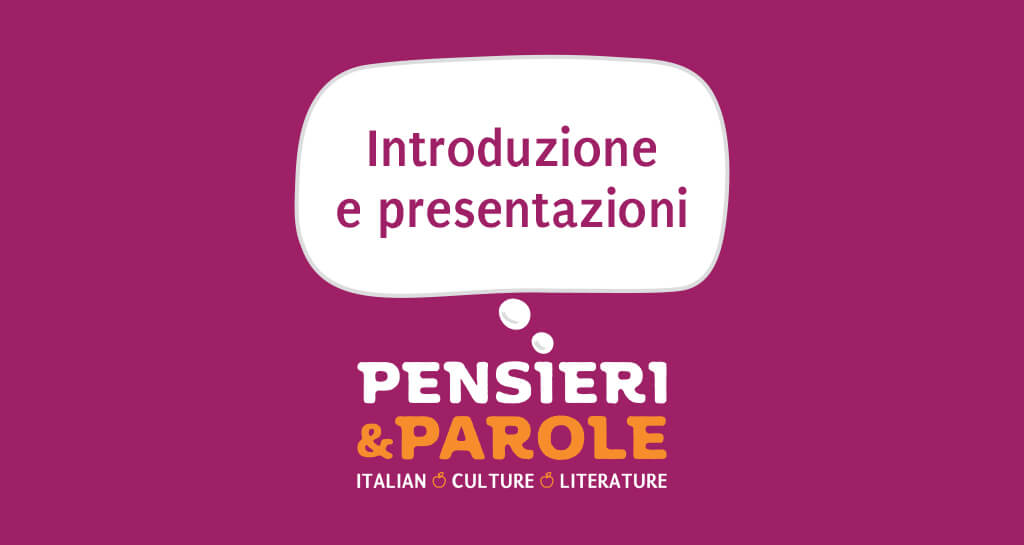Abbecedario comes from Abc and is a book used by school kids in the past. In general, it means alphabet, a list of letters or words as an approach to any language. I want to build together a virtual Abbecedario: during each episode we will focus on a word, a concept. This will be for us the starting point to explore together the Italian language and especially Italian literature. Today, discover with me 6 curiosities about words and languages. Buon ascolto!
Trascrizione:
Ciao a tutti e bentornati a Pensieri & Parole.
Oggi parliamo di: abbecedari, lingue e curiosità.
Ora, abbecedario: avete già sentito questa parola? Pensateci, ascoltate il suono: a-bbe-ce-dario, che cosa significa? Come potete immaginare, la parola abbecedario arriva dalle prime lettere dell’alfabeto: a, b, c, d. Abbecedario. L’abbecedario era un libro, un piccolo libro, un libricino per imparare a leggere e scrivere secondo il metodo sillabico, quindi dell’abc.
Perché ho scelto questa parola per oggi? Perché voglio usare questa parola, quest’ immagine, come riferimento per le prossime puntate del nostro podcast. Ogni puntata, infatti, sarà dedicata a una parola, un concetto, un’idea. Ad esempio: A come Amore e amicizia, B come bellezza, C come caffè, eccetera eccetera. Dalla parola di partenza, ogni settimana, racconterò fatti o curiosità legate alla lingua e la cultura italiane; in questo modo possiamo così costruire un abbecedario insieme, virtuale e vocale.
Parliamo di oggi: voglio dedicare l’appuntamento di oggi alla lingua e alle parole. Un abbecedario, infatti, è una raccolta di parole importanti e basiche, quelle che impariamo a scuola nei primi anni di vita. Ho raccolto alcune curiosità, quindi, sulle lingue, le parole del mondo e mi piacerebbe condividere con voi queste informazioni oggi. Sono dei fatti che io ho trovato curiosi e interessanti. Siete pronti? Andiamo, via!
Numero 1
Tutti sappiamo che la lingua italiana non è semplice. Ormai questo è riconosciuto da tutti, soprattutto dalle persone che studiano l’italiano. Forse però non tutti sanno che esiste un fenomeno che si chiama “enantiosemia”, è un fenomeno linguistico e questo nome un po’ difficile, enantiosemia, arriva dal greco. “Enantios” significa, infatti, ”contrario” e “semia” significa segno. Enantiosemia è il gruppo delle parole che indicano una cosa e il suo esatto contrario, quindi delle parole che significano due cose esattamente opposte.
Ma perché queste parole significano due cose opposte? Probabilmente questa polisemia, quindi più significati nella stessa parola, è dovuta all’evoluzione storica di questi vocaboli.
Voglio farvi alcuni esempi interessanti nella lingua italiana:
- la parola “tirare” in italiano significa sia “lanciare via”, quindi scagliare (ad esempio tirare una palla), oppure “attrarre a se” (ad esempio: tirare una corda). Quindi quando tiriamo un oggetto verso di noi e anche quando lo allontaniamo.
- la parola “ospite” è interessante perché la parola “ospite” significa sia “chi ospita” e sia “chi ha ospitato”, indica la persona che riceve qualcuno in casa, ma anche la persona che è ricevuta.
- una “storia” e sia “un racconto inventato” (ad esempio la storia di Biancaneve), sia una “storia reale” (ad esempio la storia della Prima Guerra Mondiale).
- “affittare” in italiano significa sia “dare in affitto” (esempio: affitto la mia casa a un amico), sia “prendere in affitto” (ad esempio: ho affittato una casa al mare per le vacanze).
- un’ultima, un ultimo esempio può essere la parola “pauroso”. “Pauroso” è sia una cosa che “fa paura” (esempio: ho visto un film pauroso), sia “una persona che prova paura” (ad esempio: Camilla è una persona molto paurosa).
Numero 2
Quante lingue si parlano al mondo?
Non posso oggi darvi un numero preciso perché questi calcoli non sono proprio esatti, ma possiamo parlare di 7097 lingue più o meno, che sono parlate oggi. Questo numero è in continuo cambiamento. Primo, perché impariamo di nuove lingue ogni giorno, quindi alcune lingue non sono ancora conosciute, e anche perché le lingue stesse sono in cambiamento. Ci sono lingue che cambiano, lingue che scompaiono, nuove lingue che nascono, però possiamo parlare approssimativamente di un numero: di questo numero 7 mila lingue che sono parlate oggi. Ma, è interessante sapere che il 75% degli abitanti del mondo parla più di una lingua e la Bibbia, il libro più tradotto al mondo, è disponibile in 2454 lingue.
Numero 3
C’è una lingua in Messico che si chiama ayapaneco, non so se ho pronunciato bene, comunque questa lingua rischia di scomparire: è solo parlata oggi da un piccolo gruppo di persone. Un linguista, Jonathan Ranger, stima che ci siano più o meno 15 parlanti, 15 persone che parlano ancora questa lingua. Però, in generale, possiamo parlare di almeno 2400 lingue che sono classificate come in pericolo, cioè che rischiano di scomparire, perché i parlanti sono meno di 1000 persone.
Numero 4
Sulle isole Canarie, in particolare alla Gomena, si parla una lingua chiamata “silbo gomero” costituita da quattro consonanti, altrettante vocali; quindi, quattro consonanti, quattro vocali e più di 400 vocaboli, parole, articolate esclusivamente con i fischi. Sapete che cos’è un fischio? Un fischio è questo.
Gli abitanti di quest’isola in particolare, che in particolare sono pastori, usano questo linguaggio perché devono parlarsi a grande distanza; per rendere il fischio più forte, mettono una, due o tre dita in bocca e usano le mani come megafono. Ci sono regole grammaticali e fonetiche precise e queste permettono di sviluppare veri e propri discorsi; è così forte che possiamo udirlo, ascoltarlo fino a 5 km di distanza. È stato inventato dagli aborigeni guanci che usavano questo linguaggio per comunicare tra le grandi valli che vedono l’isola. È stato poi adottato successivamente dai colonizzatori spagnoli, è stato usato per secoli e poi è iniziato, ha iniziato a scomparire nel corso del 1900. Poi dal 1990 il governo delle Canarie ha iniziato dei progetti per inserire questa lingua nelle scuole.
Numero 5
E le lingue artificiali? Beh forse conoscete l‘esperanto. L’esperanto è una lingua artificiale e parlata da un numero di persone che varia dai 500 mila e due milioni. È stata usata in due film girati fra il 1964 e il 1965. Questa lingua è stata sviluppata fra il 1872 e il 1887 da un polacco di origini ebraiche: Ludwik Zamenhof, non so se ho pronunciato bene, forse gli ascoltatori polacchi possono mandarmi un messaggio e correggermi, in caso.
Possiamo oggi contare fino a 2 milioni di persone a livello mondiale che parlano o capiscono l’esperanto in diverso grado, includendo circa 1000, da 1000 a 2000 persone, che sono nate come parlanti nativi, quindi che parlano esperanto dalla nascita. Questo è molto interessante, pensate a questa questo fatto: l’idea di creare una lingua, creare una lingua da zero, e creare delle persone che utilizzano questa lingua in un modo materno, la lingua madre; è molto interessante.
Qual è il paese in cui sono parlate più lingue?
L’India ha più lingue ufficiali di qualsiasi altro paese del mondo, sono 22. In ogni caso, è importante notare che queste lingue non sono ufficiali a livello nazionale, ma sono ufficiali a livello regionale. Se invece parliamo di lingue ufficiali nazionali, allora lo Zimbabwe ha 16 lingue ufficiali, più di qualsiasi altra nazione. La lingua più isolata del mondo, nel senso che l’unica lingua sulla terra che non è direttamente collegata nessun’altra, è la lingua Basca che viene parlata nelle regioni di confine tra la Spagna e la Francia.
Ultimo fatto curioso
Ci sono anche le lingue di fantasia. Il caso forse più famoso è quello del popolo Klingon, il popolo guerriero di Star Trek. Questa è una lingua artificiale inventata da un linguista che voleva dare credibilità al film, alla serie televisiva. Non è l’unico, ci sono altri casi di lingua artificiale nella letteratura, nel cinema e nella televisione. Forse conoscete, ad esempio, Arancia Meccanica di Stanley Kubrick: i protagonisti del film parlano una lingua inventata mixando inglese e russo. Oppure, un altro caso celeberrimo che tutti noi conosciamo, è il caso di Tolkien, il creatore della saga del Signore degli Anelli. Prima di diventare celebre come scrittore, Tolkien era un filologo. Per i suoi romanzi pensate che ha creato la grammatica e il vocabolario dell’elfico e di altre 10 lingue.
Le curiosità di oggi finiscono qui, spero che siano state interessanti per voi. Torniamo la settimana prossima con la prima lettera dell’alfabeto, la lettera A. Se nel frattempo tempo volete sentire qualcosa di particolare nel podcast, volete farmi una domanda particolare, oppure vi piacerebbe esplorare dei temi particolari, potete semplicemente contattarmi, mandandomi un’email, visitando il mio sito oppure la mia pagina Facebook. italiano Vi ringrazio ancora per l’attenzione e per l’ascolto e vi auguro una buonissima settimana
Fonti e link utili: